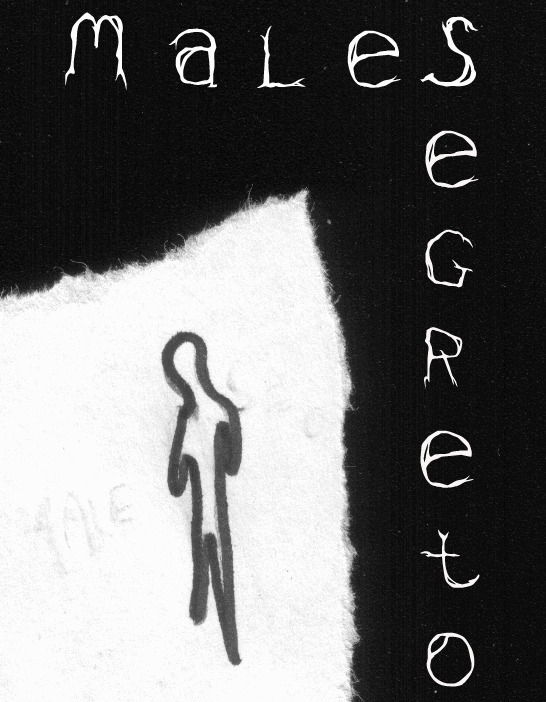CIMITERO DEL SUD
Il treno si ferma stridendo sotto le pensiline; l’odore di ferro surriscaldato e il calore della motrice rendono l’aria irrespirabile.
Fa molto caldo nella grande città del sud. Augusto Mozzi vi si trova per una promessa fatta alla vecchia madre, emigrata tanti anni fa: visitare le tombe di famiglia ed appendere ai loculi alcuni rosari.
Sono solo le otto del mattino ma il sole scotta già sulla pelle e l’aria umida ed immobile è inquinata e pesante. Lasciato il suo bagaglio al deposito, Augusto decide di sbrigare al più presto quell’obbligo che lo fa sentire anche un po’ stupido. Esce dalla stazione e si avvia verso la fermata del mezzo pubblico.
Per fortuna l’autobus non è affollato, ma lo spostamento non è comunque piacevole: il caldo si è fatto addirittura insopportabile, quasi quanto l’odore di plastica e di gomma.
Il cimitero si trova nella parte alta della grande città, che è sovrastata da colline franose. Arrivarci richiede un certo tempo, sia per il traffico sempre molto intenso in centro, sia per le salite lungo ripide stradine che spesso sono ingombre di automobili e di persone ai bordi della carreggiata.
L’autobus si ferma nel grande piazzale, stranamente vuoto in confronto al caos della città.
Il cimitero è immenso. Le sue mura corrono dalla sommità del colle su cui giace e scendono verso il centro scomparendo lungo la discesa. Dal di fuori Augusto vede enormi cipressi e cupe, maestose cappelle funebri.
- Quattro mazzi di fiori, per favore- e dal chiosco non riesce a staccare lo sguardo da quelle architetture solenni e bizzarre. Dopo aver chiesto informazioni ai custodi sull’ubicazione delle tombe, Augusto varca infine l’enorme cancello di ferro.
Lungo i viali non ci sono ombre, il sole è a picco e il cimitero è deserto. Nonostante qualche frinìo di insetti tutto è immerso nel silenzio: è l’immobilità del mezzogiorno d’estate che sembra rallentare ogni cosa, che sembra sfinire anche il fluire del tempo.
I cipressi sembrano muti guardiani a custodia delle tombe che si susseguono senza fine. Alcune sono curate e lucide, altre sono annerite e decorate soltanto da muschi.
Il cammino sta diventando decisamente lungo e faticoso. Augusto pensa di aver sbagliato ad orientarsi, ciononostante continua, fermandosi di tanto in tanto per asciugarsi il sudore e guardarsi attorno. Finalmente comincia la zona dei “palazzi”.
Augusto costeggia queste costruzioni enormi, alte cinque piani con uno spazio vuoto tra un piano e l’altro per far passare l’aria e la luce, senza finestre, tutte uguali, tutte mute. Si aggira per questa città fantasma abitata da non vivi finché giunge al palazzo della confraternita di Sant’Antonio, dove dovrebbero essere sepolti i suoi lontani parenti.
Nell’ombra dell’interno del palazzo si vedono chiaramente centinaia di lumini, uno per loculo: trovare le sue tombe sarà un’impresa. Sebbene spossato dalla calura e dalla sete si appresta a salire le scale; dalla rampa guarda la macchia mediterranea che stenta sopra le brulle colline della città del sud.
Ha già salito due piani quando un forte odore di gas gli invade le narici stordendolo. Non è gas: sono le esalazioni di quelle migliaia di corpi in disfacimento, artigli che chissà da che arcane incrinature del marmo e del cemento riescono tuttavia a farsi strada verso l’aria, verso la luce.
Uno strano sgomento si impossessa di Augusto. Si guarda intorno: i corridoi lunghissimi e semibui sono costeggiati da pareti altissime che convergono sopra di lui con luccichii confusi. Si sente piccolo, infinitamente piccolo (ma com’è possibile che questo palazzo sia diventato improvvisamente così immenso?), schiacciato dal peso di quei corpi che lo sovrastano inanimati.
In un ultimo slancio vitale Augusto vorrebbe urlare ma non sente alcun suono vibrare nella sua gola e nell’aria: c’è solo silenzio e distanza, immensa distanza da tutto. Disperato, allo stremo delle forze cerca di raggiungere la rampa delle scale per fuggire, quella rampa lontanissima come se stesse guardando tutto con un cannocchiale al contrario. Corre e boccheggia, si trascina, inciampa e rotola.
Devono essere trascorse parecchie ore. Augusto si trova disteso per terra all’ombra di un cipresso, qualcuno gli sta bagnando la testa con un piccolo innaffiatoio per i fiori.
Un infermiere gli inserisce la flebo nel braccio.
-Cosa mi è successo? Mi portate in ospedale?-
-Probabilmente è disidratato ed ha avuto un colpo di calore. Le faremo solo alcuni controlli. Se tutto sarà a posto domani potrà già essere fuori.-
-Ma... io devo tornare, devo appendere i rosari-
L’ambulanza comincia la sua discesa verso l’ospedale. Augusto viene risucchiato nella grande città.
Sua madre non l’ha mai più rivisto.
LABIRINTO
-Anche per oggi è finita-
Roberto indossa il cappotto ed esce dal palazzo di vetro: dopotutto è giusto che una compagnia di assicurazioni ostenti una certa opulenza. E in fondo non è il caso di fare falsi moralismi perché lui di quell’opulenza ci vive e grazie ad essa ha potuto conquistarsi un ruolo di prestigio pur non avendo ancora trent’anni. La direzione stima molto questo giovane preparato, estroverso e dinamico che lavora con serietà ed ambizione. Il suo lavoro di consulente infatti gli piace molto, ma a Roberto non interessa il contatto con la clientela, il riuscire a creare un dialogo ed un rapporto di fiducia con l’assicurato e il concludere la trattativa con l’operaio, il professionista, la casalinga. No, a lui piace comandare i numeri!
Gli piace vagare tra le formule del montante, del capitale e riuscire a dominarle, scoprire che alla fine il risultato che ottiene è esattamente quello che si aspettava. Il suo lavoro è per lui come un fantastico labirinto in cui perdersi sapendo di trovare comunque un’uscita.
C’è qualcosa di tristemente rassicurante in quei numeri che non parlano, non giudicano, non hanno nessuna opinione: lui ne è il padrone, il tiranno di quel popolo muto e infinito.
-Buongiorno a tutti!- esclama distratto dal titolo di un quotidiano economico posato sulla sua scrivania.
-Ciao Roberto. Hai sentito? E’ morta la vecchia Valier.-
La notizia della morte di un cliente invade di solito gli uffici provocando un lieve sussulto che si sforza di sembrare di compassione, ma che è di pura curiosità. Il sussulto, improvviso come è comparso, si dissolve nell’animo degli impiegati già occupati a cominciare il lavoro. Il collega di Roberto ha lo sguardo delle grandi occasioni: la Valier era una delle migliori clienti e aveva investito somme considerevoli nei prodotti della compagnia, come d’altronde tutto il resto della famiglia di nobili e ricchi veneziani, e ci si dovrà preoccupare di evitare una eventuale perdita di raccolta che deriverà dalla liquidazione delle polizze della nobildonna.
-Vianello, l’aspetto da me!-
Roberto immagina già che cosa vuole dirgli il direttore. Si aggiusta la cravatta ed entra nell’ufficio.
-Si sieda! Forse avrà già sentito che è morta la signora Valier.-
-Sì, me l’hanno detto.-
-Ecco, l’ho chiamata perché gli eredi ci hanno chiesto un incontro per conoscere nei dettagli il tipo di investimenti posseduti dalla signora. Si tratterebbe di andare dai Valier nella loro casa di Venezia per illustrare la situazione alla presenza del loro avvocato e volevo solo spiegarle alcuni dettagli.-
Roberto gode della piena fiducia dei suoi superiori. Del resto tutto il suo lavoro è basato sulla fiducia.
La stazione di Venezia è più animata del solito. Solo adesso Roberto ricorda che si sta avvicinando il culmine del carnevale. E’ simpatico il vociare che si sente per le calli, e la carrellata di personaggi che si incontrano in questo periodo dell’anno a Venezia, ha dell’incredibile. Certo è un peccato non poter prendere parte alla festa, ma a dire il vero tutti quei turisti adesso gli sono d’impiccio, visto che ha un appuntamento importante da rispettare: deve assolutamente affrettare il passo almeno fino a metà della Strada Nuova, poi si sarebbe diretto verso Campo dell’Abbazia con più calma. Suo malgrado non riesce a dribblare quella folla chiassosa e variopinta: cammina nervosamente, urta i passanti, si sposta da una parte all’altra della strada per superare un gruppo di ragazzi o di anziani turisti, ma poi deve rallentare nuovamente. A nessuno interessa della vecchia Valier e di quel giovane impiegato con un compito tanto importante da svolgere.
La calle si restringe.
Roberto sente il calore degli altri corpi, il loro respiro sfiorarlo; il suo sguardo si perde negli occhi impazziti di un giullare o in quelli glaciali di una dama di corte. Tutto è diventato un caleidoscopio, un giocattolo cattivo di cui non riesce più a sopportare gli infiniti colori, il vociare allegro, i brusii, i respiri.
Il respiro....Il respiro sembra mancare!
-Dov’è, dov’è quel campo maledetto! Dov’è che devo girare?-
Roberto infila un sottoportico buio, un inaspettato buco nero che è apparso improvvisamente al suo fianco. Mentre lo percorre, il rumore dei suoi passi riempie lo spazio scuro che sembra inghiottire i suoni ormai lontani della Strada Nuova. Non ha idea di dove sarebbe finito: perdersi a Venezia è facile, ma non importa; importa soltanto evitare quella folla mostruosa, quell’unico essere con migliaia di facce e di voci diverse. Roberto continua a vagare tra le calli deserte, tra fondamenta sempre più strette che lo stringono tra le fredde mura e l’acqua impenetrabile dei canali. Ogni tanto si guarda intorno nella speranza di trovare un passante a cui chiedere un’informazione, ad ogni ponte si ferma per capire dove possa trovarsi ma non riesce, non riesce più a capire che razza di assurdo labirinto si sia creato attorno a lui. E’ tutto così strano, così stretto e da ogni singolo mattone trasuda un’idea di vecchiezza e di decadenza. Ogni palazzo gli sembra in rovina, in bilico sull’abisso del tempo, sul punto di franargli addosso tutta la muffa e il peso di secoli. Roberto sta male, ha la nausea, suda, gli sembra di non potersi più reggere in piedi. Preso dalla disperazione, usa tutte le sue energie per mettersi a correre e cercare di fuggire da tutto quello che lo circonda, ma sapendo di non poter trovare alcun rifugio.
Attraversando i campi e le calli senza accorgersi di quello che vede, gli sembra di vagare in uno spazio sconosciuto e insondabile finché, stremato, è costretto a fermarsi. Si accascia sopra ad un gradino. Il cuore sembra volergli uscire dal petto per prendere l’aria che non riesce ad arrivare ai polmoni.
Guardandosi attorno vede qualche passante camminargli di fronte: una vecchietta con la spesa, due ragazzi abbracciati, una suora. Il rumore di quei passi riemerge dal nulla, come risorto da un silenzio infinito, e insieme ad essi un suono sommesso: il brusio della vita lenta che governa Venezia.
Con meraviglia si accorge di essere a pochi passi da Palazzo Valier.
Sorpreso e ancora turbato guarda immediatamente l’orologio: certo un po’ di ritardo gli sarebbe stato perdonato in un periodo particolare come quello del carnevale. L’importante è essere arrivati nonostante tutto, e in ogni caso un momento di stanchezza può capitare a chiunque: non era il caso di preoccuparsi troppo! Roberto si asciuga la fronte con il fazzoletto, ravviva i capelli, sistema la giacca e il nodo della cravatta. Infine suona il campanello di ottone.
-Sentite condoglianze da parte di tutta la società, e mie personali!-
-Allora, signori, la maggior parte del patrimonio della signora Valier è costituito da una polizza vita che ad oggi ha reso circa il venti virgola sette percento.-
SCHERZETTO!
Era un pomeriggio tiepido e afoso di metà settembre.Alberto si siede dentro la sua automobile arroventata dal sole stanco ma ancora capace di surriscaldare le lamiere. Non si accorge che sul longherone laterale è posata una cimice entrata da chissà dove: in questo periodo, si sa, le cimici sono ovunque. Dicono che vivano nei campi di soia.Mette in moto la macchina ed accende la radio. Un motivetto banale ma orecchiabile riempie l’abitacolo e Alberto si avvia verso il centro commerciale lungo uno stradone rettilineo ma piuttosto stretto, costeggiato da fossati e platani, come ce ne sono tanti in campagna.Non c’è molto traffico e si può viaggiare in tranquillità: sigaretta accesa, finestrino abbassato, braccio a fendere l’aria.Un ronzio piuttosto sordo richiama l’attenzione di Alberto che abbassa il volume e appoggia entrambe le braccia sul volante. Il ronzio non cessa, sembra farsi più lontano ma poi improvvisamente si avvicina: Alberto volta rapidamente la testa due o tre volte quando vede la cimice volargli verso il volto. É strano come il terrore per qualcosa di assolutamente inoffensivo possa impossessarsi di un uomo e renderlo incapace di agire sensatamente: una smanacciata scoordinata, una brusca torsione del capo; poi un tonfo metalloplastico e rumore di vetri infranti. L’auto era accartocciata ai piedi del platano. Nell’aria si spandeva ancora il motivetto insulso; sordo ascoltatore un fantoccio disarticolato sul sedile anteriore.Non sono mai state chiarite le cause dell’incidente: l’autorità giudiziaria non ha ritenuto opportuno procedere all’autopsia. Tutti avevano pensato ad un malore improvviso: non c’erano tracce di frenata e del resto era noto che Alberto assumeva abitualmente psicofarmaci. E così il destino ha atteso Alberto in un pomeriggio di fine estate: un insetto verde, un giullare a sei zampe venuto dai campi di soia che si è esibito nella sua burla fatale. Viene quasi da ridere.Ora l’auto giace in un campo di demolizione alla periferia della città.
Sui tappetini anteriori è rimasto, zampe all’aria, un cadaverino marrone.
MANAGER
La Mercedes sibila e brontola sordamente nel fitto della notte. Si sentono chiaramente solo lo sfrigolio delle ruote sull’asfalto e l’aria odorosa di fiori e motore che entra dal finestrino semiaperto.
Antonio Giudici è uno di quei fortunati per i quali la vita è un’avventura e una sfida continua, e vincono. Amministratore delegato di una società finanziaria, è abituato al successo e tuttavia lo rincorre continuamente provando ad ogni traguardo raggiunto una gioia feroce ed acerba, come fosse ancora agli inizi della carriera. Certo, di strada ne ha fatta: figlio di una ricca famiglia di città, ha frequentato collegi ed università prestigiosi ed ha scalato tutti i gradini del potere. E non è il caso di dare troppo peso a qualche spinta avuta da amici influenti ed a qualche tiro mancino: alla fine è il risultato che conta, nella vita come in azienda, e lui non tollera insuccessi. Anche l’ultima assemblea degli azionisti, dalla quale sta tornando, è stata l’occasione di ottenere il consenso di quella parte di investitori che nutrivano ancora dubbi sul suo operare spericolato e di rinsaldare ulteriormente la sua leadership.
Si accende la spia della riserva. La campagna ai bordi della statale è quieta e solo qualche auto gli viene incontro ruggendo e lasciando scie di luce rossa e di bruciato.
Il ticchettio della freccia diventa chiaro allorché comincia a rallentare. Accosta alle pompe ed estrae, magnifica pistola, il portafogli.
-Hai da accendere?- gli chiede un giovane trasandato sceso da un’Alfa anch’essa fermatasi al distributore. Quel “tu” da ad Antonio un senso di fastidio e disagio.
Tira fuori l’accendino. Non fa in tempo a porgerlo al giovane di fronte a lui che un dolore dapprima sordo ma che esplode lentamente in tutta la testa, lo stordisce e lo fa barcollare.
Il teppista gli sfila di mano il portafogli in silenzio e fa per andarsene. Antonio non grida aiuto, sa che nessuno lo sentirebbe. Sconvolto dal dolore e dall’odio, solo di fronte ad un nemico che già se ne va vittorioso, riesce soltanto ad urlare: -Bastardo! Figlio di puttana!-
Il delinquente si gira con sorriso beffardo e si avvicina a lui, che resta appoggiato alla pompa di benzina. Non fa in tempo a difendersi. Con gli occhi chiusi sente soltanto dei colpi che gli fanno girare la testa. Qualcosa si rompe nella sua bocca: avverte una sapore dolce e nauseante.
L’equilibrio gli manca di colpo. L’asfalto è duro e ruvido e Antonio Giudici sente i palmi delle mani e le ginocchia bruciargli. I colpi non si fermano: dalle sue visceri si propagano dolori che si espandono come colpi su pelli di tamburo e le gambe sembrano esserglisi staccate dal resto del corpo.
Alla fine, sopraffatto dal dolore, non riesce più a distinguere le luci del distributore. Sviene.
Quando si sveglia, riuscendo a malapena a muoversi, guarda le mani e il vestito: a stento riconosce sé stesso e comincia a piangere, senza ritegno, come un bambino.
LA LETTERA DI A.
A. si è ucciso con un colpo di pistola una mattina dell’agosto 2003, pochi giorni dopo il suo compleanno. Ha lasciato ai suoi cari una lunga lettera in cui spiegava i motivi del suo gesto e la sua visione del mondo. Per amore nei suoi confronti e per rispetto nei confronti della famiglia, ne riporto soltanto la parte centrale nella quale A. fa un’analisi disperata della realtà, censurando le parti destinate ai famigliari ed alle persone che gli erano più vicine.
“…Infine, in cinquemila anni di esistenza dell’uomo, nulla è cambiato. Ci illudiamo di vivere in società civili ma, ripeto, nulla è cambiato. Ancora l’uomo uccide, tortura, mutila, violenta. Ancora in situazioni di pericolo l’amigdala stimola il rilascio di adrenalina che fa aumentare la pressione sanguigna e l’apporto di sangue ai muscoli e di ossigeno ai polmoni. Ancora l’uomo si ammala e muore, e spesso a causa di sostanze da lui stesso create. Oppure lascia che molti altri muoiano di fame o di malattia, quando tutti potrebbero essere nutriti e curati.
Ancora esistono guerre scatenate da motivi di interesse economico o di controllo del territorio, per motivi etnici o religiosi: le armi sono sempre più sofisticate, ma in mancanza di meglio vanno ancora bene coltelli e machete.
Ma soprattutto le necessità primarie e la sostanza dell’esistenza sono rimaste le stesse: è cambiato soltanto il modo di far fronte ad esse. L’uomo dorme ancora di notte, ha bisogno di bere e di mangiare con una certa regolarità e biologicamente la sua capità di adattamento è addirittura diminuita.
Come un primitivo, ancora l’uomo esce di casa al mattino per la necessità di procurarsi il cibo, soltanto che ora non se lo procura più direttamente: gli vengono dati dei soldi per comprarlo in cambio delle sue prestazioni. Alla sera, dopo una giornata di “lavoro-caccia”, torna alla sua “casa-capanna” a riposare. Invece di incidere la roccia, dipinge quadri, invece di erigere monoliti crea sculture, al posto di danze tribali usa sofisticati strumenti elettronici, non ascolta più le storie degli anziani e degli eroi ma guarda la tv. E veramente, più di una volta mi sono chiesto perché siamo ancora tanto attratti dai gioielli e dai metalli luccicanti in genere…
Quanta ipocrisia ha generato l’uomo nel corso della sua storia: non siamo null’altro che animali pensanti.
Ancora sembra naturale avere dei figli, garantire la prosecuzione della specie, tramandare il nostro dna, corteggiando gli elementi dell’altro sesso e litigando e perfino uccidendo per raggiungere l’accoppiamento, quando forse sarebbe molto meglio evitare ad un'altra creatura le sofferenze della vita ed evitare di disperdere il proprio tempo e le proprie sostanze nell’accudimento di un cucciolo d’uomo.
Si sono diffusi infiniti galatei per soffocare la nostra essenza, sono state emanate leggi, è stata impartita l’educazione, ma non è stata eliminata la violenza: di inchini e coltelli è stata fatta la nostra civiltà...
Ora, a seconda che noi condividiamo o meno la sua visione del mondo, essa merita comunque il nostro rispetto per le conseguenze che ha avuto sulla vita di A. stesso, e dei suoi cari.
STORIA DI LUCA
I
Il treno si mise in moto pigramente. Dai finestrini Luca guardava la campagna incolore e silenziosa di nebbia, perdendosi in quello sfondo leggero e vischioso ad un tempo.
In città la vita cominciava già a riempire i viali e gli autobus, infreddolita e assonnata, impacciata nel grigiore tipico degli inverni padani. A Luca non importava un gran che, anzi si sentiva quasi a suo agio in quella luminescenza opaca. Dopotutto, pensava, quel nulla che avvolge ogni cosa, freddo e pesante, aveva imprigionato anche le sue emozioni da quando, finita l’adolescenza, era riuscito a trovare un buon lavoro.
E tuttavia era inquieto, perché il silenzio delle emozioni viene riempito dall’angoscia del vuoto. Lo spaventava soprattutto la coscienza che il suo silenzio, il suo blocco emotivo, fosse l’estrema, suicida difesa di un animo ipersensibile alle suggestioni della natura e dell’arte ma anche, e se ne doleva, alle difficoltà del vivere, del lavorare, del convivere con tutto ciò che la sua natura tanto ingenua e bonaria quanto insicura e dimessa, temeva e schivava.
Poteva forse dire di avere paura di vivere, e con tutto sé stesso esprimeva un bisogno di fuga e un senso di fatica: i suoi pensieri erano coerenti e precisi ma sembravano sempre arrivare in ritardo rispetto allo stimolo che li aveva prodotti, il suo incedere era nervoso ma incerto, e da tutto ciò traspariva a chi lo conoscesse tutta l’ansia per qualcosa di indefinibile che raramente lo abbandonava. Anche la sua pelle, che nei periodi di stress si arrossava e si desquamava sembrava rispondere all’invadenza quasi corrosiva che la realtà rappresentava per lui.
Era ancora chiaro quando uscì dal lavoro. Per fortuna era venerdì e poteva avviarsi alla stazione senza fretta: i suoi pensieri erano infatti scanditi dall’orario dell’ufficio e dall’ossessione del risveglio mattutino. Viveva in un giorno che non finiva mai poiché era già proiettato sulle preoccupazioni del domani.
Sapeva di aver perduto sé stesso e oscillava continuamente tra il desiderio di lasciarsi andare alle suggestioni destate dal suo animo inquieto e quello di possedere il pragmatismo dei suoi colleghi e superiori, restando paralizzato in tutto il suo essere e sentire.
-Scusa, ti sono cadute le sigarette.-
Una voce delicata che sembrava venire da immensamente lontano lo risvegliò bruscamente dai suoi pensieri, riportandolo al rollio del treno in corsa. Guardò, come se cercasse di vedere al buio, da dove provenisse il suono: la sua compagna di scompartimento lo guardava sorridendo. Era una ragazza decisamente strana, dai lunghi capelli rossi, pelle rosea, corpo sottile. Vestiva con abiti di dubbio gusto: un giaccone multicolore, dei pantaloni verdi attillati, delle scarpe a punta color pastello. Sembrava quasi uno strano fiore antropomorfo, un essere dei boschi. Una fata....
Qualcosa vibrò nell’animo di Luca.
-Grazie- disse sorridendo mentre raccoglieva il pacchetto di sigarette -ne vuoi una?-
-Mmh... sì, grazie!-
-Mi chiamo Luca.-
-Monica, ciao.-
Si accesero una sigaretta. Luca era incuriosito, voleva sapere di più di quella strana fata. Le chiese dove stesse andando.
Man mano che le sigarette bruciavano e il fumo riempiva dolcemente lo scompartimento anche Luca si sentiva riempire di calore e di simpatia nei confronti della ragazza e, sebbene fosse solamente su di un pigro treno per pendolari, lo rapì la sensazione del viaggio: un viaggio che non fosse soltanto il tratto casa-lavoro, ma che continuasse senza una meta così come continuava la sua conversazione con Monica, che li stava conducendo lontano parlandosi di loro stessi e confidandosi quei piccoli segreti che, come accade talvolta, si confidano solo agli sconosciuti. A Luca era già capitato: lo sconosciuto è l’uomo che non si sentirà più parlare e che dopo essersi salutati non esisterà più. Perciò si stavano scoprendo così a fondo: lo sconosciuto è l’uomo che non sa, che non ha mai saputo.
Il treno cominciava a rallentare. Presto sarebbe arrivato in città e la sconosciuta avrebbe continuato il suo viaggio, ognuno portando con sé i segreti dell’altro.
Per tutta la sera Luca ripensò a quell’incontro e al viaggio dei suoi piccoli segreti che la fata si era portata via.
II
Il treno non era più lo stesso da quando Luca aveva incontrato Monica. Prima quel tragitto dalla sua casa all’ufficio non esisteva: era tempo vuoto, completamente inutile. Ora invece lo coglieva una smania di vivere anche quella mezz’ora dondolante e noiosa. Forse sperava soltanto di rivedere Monica, di rituffarsi dentro sé stesso per scoprire di avere una storia da raccontare.
La voglia di un incontro, il bisogno di una compenetrazione tra la sua vita e quella degli altri lo assaliva improvvisamente e, divorato dalla solitudine, spesso la sera vagava per i locali della sua città: voleva sentire la vita, un brulicare di vite scorrergli accanto con la speranza di poterne afferrare una. Altre volte, il fine settimana imboccava l’autostrada di notte con la sua auto e vagava fin quando lo coglieva il sonno, quasi volesse liberarsi dalla noia lasciandola sulle strade che percorreva.
Ormai aveva capito che voleva vivere un’avventura: una riscoperta di sé stesso e del mondo, una nuova adolescenza. Soprattutto voleva mettersi alla prova vincendo o accettando la solitudine, tornando a sognare, a piangere, odiare, fare a botte e ubriacarsi, gioire e amare: il silenzio delle emozioni si stava infrangendo; la sua vita focomelica cominciava ad agitarsi e a gridare.
-Direttore, avrei bisogno di un mese di aspettativa.-
Aveva deciso di partire per un viaggio per dimenticare sé stesso e riscoprire i suoi diversi io, farsi avvolgere dal mondo, farsi bersaglio di tutto ciò che accadeva intorno a lui.
-Mamma, papà, mi sono preso un mese di aspettativa.-
-Perché?-
-Così! Voglio fare un viaggio.-
-E non bastavano due settimane di ferie?-
-No, sono troppo poche. E poi mi darebbe fastidio l’idea di essere in vacanza perché si sa già che prima o poi finirà.-
Sperava capissero che desiderava veramente un mese di aspettativa, di sospensione, dalla quotidianità, da quella casa, dal lavoro. Il padre di Luca, un orso inoffensivo, lo fissò intensamente; la madre, a metà stizzita e rassegnata, gli rispose di fare quello che voleva.
-Vorrei dirvi anche che quando tornerò dal viaggio cercherò una sistemazione per conto mio. So già quello che pensate ma non è una questione d’età: ho bisogno di imparare a badare a me stesso, di crescere. Penso che ormai sia arrivata l’ora.-
La discussione per Luca era finita. Le obiezioni dei genitori lo avrebbero soltanto sfiorato: stanchi di sentirsi rispondere a monosillabi, avrebbero taciuto presto. Era compiaciuto di questa sua inettitudine che diventava quasi virtù e che emergeva quando alcune conversazioni diventavano troppo accese o troppo scomode.
Quella sera non parlarono più molto.
III
Oramai mancava poco.
Sentiva già le strade del mondo chiamarlo; sapeva che i prati di qualche paese lo avrebbero ospitato, le foreste protetto, il vento accarezzato. Sperava di conoscere altri sconosciuti come lui, di parlare insieme davanti ad una birra, in auto, al supermercato.
Quel desiderio di sentirsi parte del mondo, lo stava cambiando. Si stava riaprendo alle emozioni dell’avventura, alle suggestioni della natura, ai segreti di ogni creatura, a tanti piccoli misteri.
Ora si vedeva più spesso con i suoi amici. Le giornate cominciavano ad allungarsi e tornato dal lavoro si incontrava con loro per respirare insieme l’aria tiepida di primavera. Spesso tornavano nei luoghi che tante volte avevano visitato durante l’adolescenza: fabbriche chiuse, boschetti di periferia, parchi incustoditi e case abbandonate; luoghi pieni di fantasmi e di ricordi.
Le sensazioni che Luca provava in quei momenti avevano qualcosa di ciclico e circolare: profonde e indefinite come un tempo ma vissute con coscienza e abbandono differenti, come una spirale che lo aveva condotto ad un punto analogo a quello di tanti anni fa, ma ad un diverso livello. Non era più un ragazzo; forse stava per diventare uomo.
C’è da meravigliarsi che la maggior parte delle persone non conosca la città in cui abita e ne ignori i luoghi più affascinanti e misteriosi. Allo stesso modo Luca era stato a lungo quasi un forestiero per sé stesso non ricercando più la compagnia degli amici, dimenticando le emozioni del vivere, ignorando che le paure del bambino sono così necessarie per diventare grandi. Nel suo animo c’era ora un continuo rifluire di ricordi della sua età più innocente che lo avvolgevano con tutta la loro nostalgia. Luca ne era contento: il suo non era un volgersi indietro, bensì un modo di arricchire il presente attraverso lo stupore del mondo che aveva dimenticato. E sempre di più fiorivano i suoi sogni per il futuro: l’azione e la progettualità che per tanto tempo erano rimaste sepolte nel silenzio erano riemerse con tutta la loro disperante necessità.
E lentamente scemava in lui quell’inquietudine per qualcosa che sentiva prossimo a realizzarsi, ma che ancora non era. Questo voleva forse dire diventare adulti: progettare, agire, convivere con le limitazioni imposte dal lavoro, dai soldi, dal tempo viscido e sfuggente; e tuttavia osare. Osare lasciar tutto, anche per un solo mese, un solo giorno; sognare, sognare soltanto per il gusto di farlo, come un bambino.
Improvvisamente, finalmente, il suo presente immobile era stato infranto. Non poteva più attendere: tutto era pronto. La vita lo stava aspettando appena fuori dalla sua stanza.
-Domani si parte.-
FINE